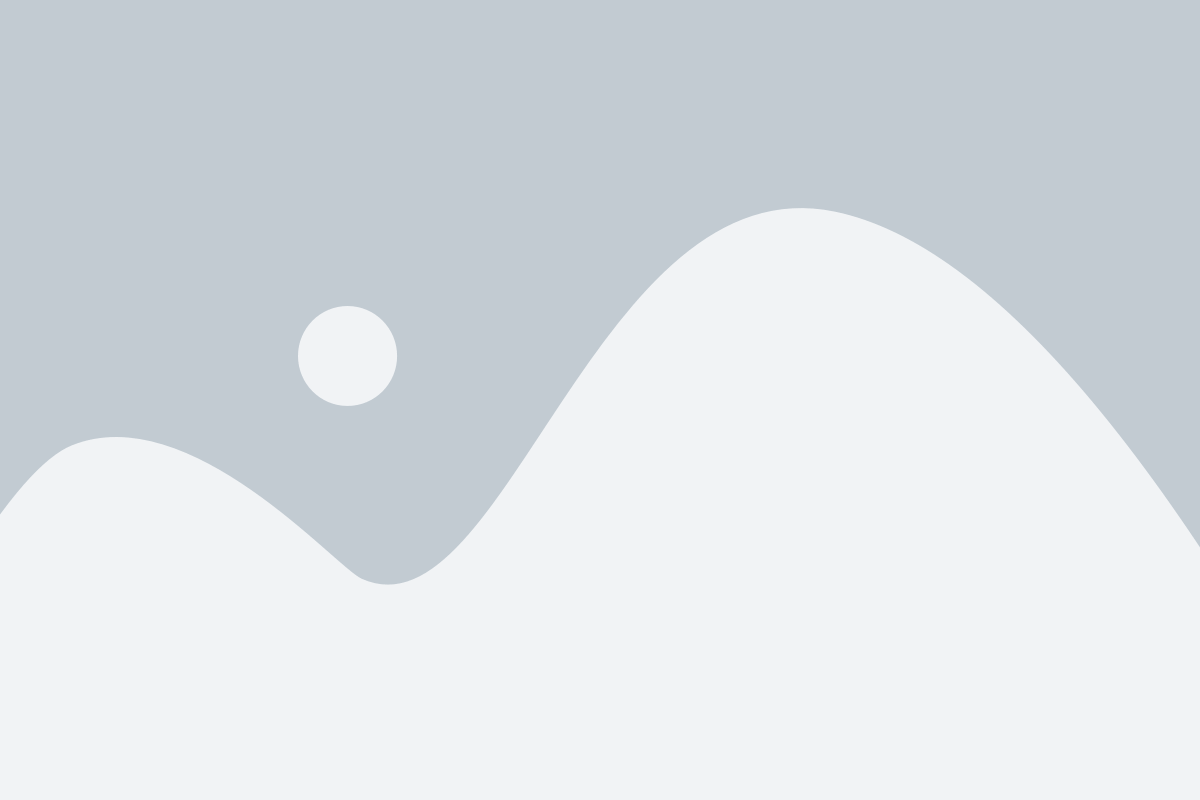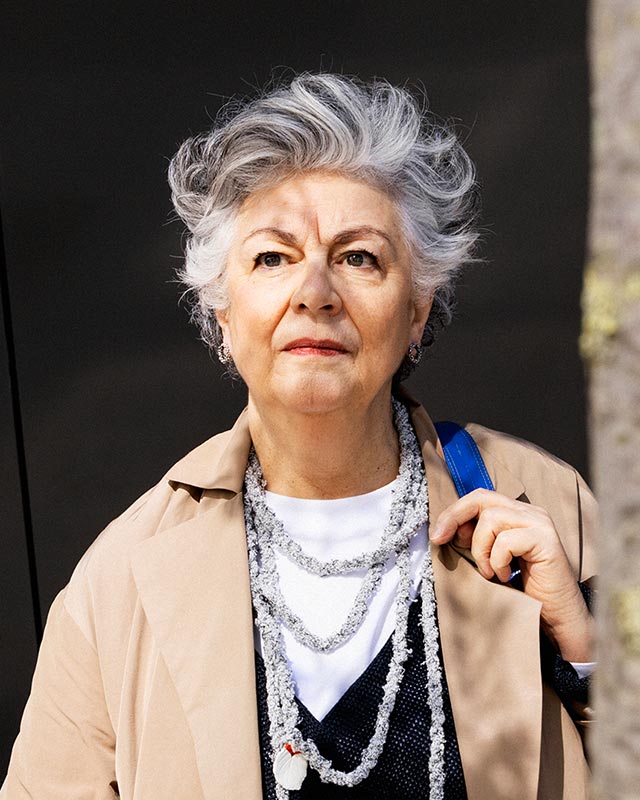© Foto: Massimo Giovannini
E’ da poco uscita la sua raccolta di poesie “Voragini d’azzurro” (Interno Libri Edizioni): Fiper ha indagato insieme ad Adriana Tasin il profondo legame esistente tra poesia e montagna, ragionando anche di attualità e sostenibilità.
Nel 2025 i poeti sono una “specie rara”. Com’è nato e come si è evoluto il suo percorso verso la poesia?
La mia poesia è germinata dalla prosa. E il termine “germinata” cade a proposito, perché così realmente è stato, come ho già espresso in una nota accompagnatoria del mio libro d’esordio (Il gesto è compiuto, puntoacapo Editrice, 2020) che qui parzialmente riporto: “Come mi sia ritrovata a scrivere poesie in età matura, riprendendo una passione giovanile, è cosa – almeno per me – sorprendente. È accaduto durante la stesura di un romanzo; all’interno della prosa nascevano spontaneamente dei versi, qua e là, un po’ come accade quando si coltiva con meticolosità un orto e tra gli ortaggi spuntano dei fiori. Come naturalista mi viene da pensare che i fiori siano spesso messi a riparo delle colture e che la biodiversità debba essere sempre salvaguardata, quale bene prezioso. Come scrittrice penso la stessa cosa. Dunque ho seguito il percorso punteggiato di poesie. Ho cercato di avere uno sguardo tridimensionale, facendomi Marco Polo di un viaggio che ho intrapreso da ferma. In fondo è questo ciò di cui abbiamo bisogno: comprendere noi stessi per poi comprendere meglio tutto il resto. Ciò richiede uno sforzo, ma richiede anche l’abbandono dei sensi che normalmente utilizziamo per decifrare la realtà. La poesia è un meraviglioso mezzo percettivo per fare questo. Non solo questo.”
Il linguaggio poetico ha la capacità di condensare, di andare dritto al punto centrale di ciò che desidera esprimere. Come una freccia. Eppure da qualche giorno mi interrogo sulla definizione «i poeti sono una “specie rara”», posta all’interno della domanda, e mi chiedo se davvero i poeti siano una “specie rara”. Di primo acchito avrei detto senz’altro: sì, ed effettivamente in un certo senso lo sono, ma riflettendo meglio credo che la vera specie rara sia ancora di più il lettore di poesia. Pare che il linguaggio poetico venga considerato lontano dal quotidiano delle persone, tanto da faticare ad aprire un varco in loro. La poesia si studia (“studiava”, per la verità soprattutto) a scuola o si trova commercializzata, come un qualsiasi bene di consumo, su pochi scaffali delle librerie. Spesso non esiste nemmeno una sezione dedicata. Ma, al di fuori di questo contesto, come sopravvive? La poesia può essere un mezzo per affrontare temi reali, per toccare l’intima esistenza delle persone, per sollevare domande? Sì, ma ha necessità di incontro, ascolto, e questo può passare in modo molto più diretto di quanto ci si immagini, purché le persone siano disposte a farsi attraversare.
La sua ultima raccolta di poesie dal titolo “Voragini d’azzurro” è interamente dedicata alla montagna. Come mai? Che rapporto ha con essa?
Sono nata in un comune montano, Tione di Trento, che si trova a 600 metri di altitudine ed è il capoluogo delle Giudicarie in Trentino, e da quarant’anni vivo a Madonna di Campiglio, una famosa località turistica, nota per le bellezze naturali e per l’attività sciistica e alpinistica. Il paese si trova a più di 1500 metri di altitudine ed è circondato dal Parco Naturale Adamello Brenta. La mia casa si trova al limitare del bosco, all’imbocco della via principale di accesso alle Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco, meta ambita degli alpinisti.
Si crede che i custodi dei monti siano coloro che li abitano, e senz’altro è così, eppure tra coloro che abitano un luogo e il luogo stesso a volte si instaura una strenua lotta per raggiungere una pacifica convivenza. La natura in montagna è magnanima, immaginifica, ma nel contempo può essere inospitale e dura. Può quindi accadere ciò che è accaduto a me, che si avverta una sorta di attrazione e di respingimento da parte del luogo dove si vive. Un sentimento che di certo non lascia indifferenti. Forte.
Nei luoghi dove vivo, il tema “morbidezza e asperità” (prendo in prestito il titolo da un reading fatto un paio d’anni fa sull’Altopiano di Asiago) è visibile anche a occhio nudo: da una parte si trovano i massicci dell’Adamello e della Presanella, dai contorni arrotondati e gelati, e dall’altra le guglie delle dolomiti di Brenta, cattedrali di pietra. Non a caso l’antico nome del Gruppo delle Dolomiti di Brenta, quello attribuitogli dalle popolazioni che lo circondavano, era Spinale o Sfulmini, per l’incupimento del paesaggio nei giorni frequenti di temporale, ma anche per le guglie che sembravano, a detta del pittore e alpinista E.T. Compton (fine ‘800), lance puntate contro il cielo, sfide sovrannaturali.
Un luogo simbolico e chi in esso vive si compenetrano fino a diventare tutt’uno. Viverci significa compiere un’esplorazione del sé. Non sarebbe stato possibile per me ignorare la potenza naturale di ciò che da sempre mi circonda.
Diverso mi pare sia l’atteggiamento di chi si reca per un periodo di vacanza in montagna, che gode appieno della bellezza dei paesaggi, magari consultando prima le previsioni del tempo. Ma chiunque può, ad un certo punto, avvertire il richiamo profondo di questi luoghi, tanto da desiderare viverci, così come è accaduto a famosi alpinisti, come Bruno Detassis e Cesare Maestri, che cominciarono, ancora da ragazzi, a salire in bicicletta da Trento con le corde in spalla o con i mezzi a disposizione, per scalare, anche in solitaria, le montagne del Brenta e rimanere, fino alla loro morte, indissolubilmente legati ad esse.
Cosa sono le “Voragini d’azzurro” che danno il titolo alla raccolta?
In verità questo titolo fa riferimento esplicito a un verso di Arthur Rimbaud, che dà il nome alla seconda sezione del libro – Forse gli abissi d’azzurro, pozzi di fuoco –. È dunque un omaggio al poeta maledetto ma è anche un titolo ossimorico, si pensi al contrasto azzurro/voragine. Siamo abituati a pensare alla voragine come a qualcosa di oscuro, qui invece si scorge il colore celeste, forse il cielo. Le voragini sono presenti tra le montagne, le fendono, ma sono anche in un certo senso dentro di noi. La ragazza raffigurata in copertina ha il mento leggermente sollevato ma ha gli occhi chiusi, dove sono realmente le voragini che sta osservando? Possiamo intuirlo.
Nelle sue poesie ricorre il tema dell’arrampicata su roccia, in parete. Cosa rappresenta per lei?
In Voragini d’azzurro affronto il mistero dell’esistenza avvalendomi di un’allegoria solida e “incantata”: la montagna. L’arrampicata è una disciplina a cui mi sono avvicinata, praticandola prima in falesia e poi su qualche via dolomitica (es. Campanile Basso), tra il 1996 e il 2000. La stesura di un verso, di una poesia, si potrebbe paragonare a un’arrampicata in falesia o in parete, dove si rende necessario affinare la propria sensibilità, gestire uno stato continuo di allerta, di sospensione e concentrazione massima. Un solo gesto – un solo verso – può far cadere oppure può aiutare a raggiungere un livello più elevato di conoscenza. È molto appagante a livello mentale compiere/trovare il giusto gesto/verso. Gli stati mentali a cui si può avere accesso in situazioni apparentemente distanti tra loro possono assomigliarsi. È il tema centrale della mia ultima raccolta (Voragini d’azzurro) il parallelismo tra poesia e arrampicata. La prima parte della raccolta rappresenta la prima parte della vita, quella in cui si è impegnati a fare un percorso difficoltoso che ci assorbe nel “qui e ora”, aggrappati a un appiglio, appesi all’incertezza della vita che sta prendendo forma, concentrati sul gesto da compiere. Il percorso è rischioso, aleggia la morte intorno. L’alta quota è l’interregno di vivi e morti, apparizioni e sparizioni, illuminazioni e stupori. Ma è necessario proseguire il percorso e scoprire cosa c’è oltre la cima (cosa c’è al di là?) comprendere che i nostri ritmi vanno cambiati e pure le prospettive, che è arrivato il momento di rivolgere lo sguardo altrove. Diventiamo noi stessi parte dell’ambiente che ci circonda… diventiamo parte del tutto.
Da www.Laboratoripoesia, stralcio recensione a “Voragini d’azzurro” a firma Camilla Ziglia: «E la roccia lascia fare, trasfigurata ormai in mondo altro, oltrevita e non-luogo delle anime, ammantata del fascino del pericolo in parete che sfida l’uomo a farsi parete (quasi un canto di sirene), del richiamo a nozze mistiche in unione con la natura, del paesaggio che si fa piccolo e immenso, muto, allontanato in dimensioni oltreumane.»
Al di fuori delle metafore poetiche, come vede la montagna oggi? Qual è il suo stato di salute? Quali le azioni da fare per preservarne la poesia?
La vedo “calpestata”, nel senso più ampio del termine. Purtroppo il turismo di massa si concentra soprattutto in alcuni luoghi noti e in periodi particolari dell’anno. Tutto spinge nella direzione del sold out, del fare in modo che ci sia un numero crescente di presenze. Si potenziano gli impianti di risalita, si facilitano i percorsi di accesso, quali strade asfaltate e sentieri allargati, in modo tale che sempre più persone abbiano accesso rapido alle alte quote, alte quote che purtroppo pagano lo scotto del cambiamento climatico, lo vediamo bene osservando lo stato di salute di un ghiacciaio quale ad esempio è l’Adamello. Le temperature sono in aumento. I gas climalteranti vanno ridotti. Non c’è altro modo di tornare indietro dall’attuale situazione e non basterà prendere atto che il clima sta cambiando, coprire i ghiacciai con dei teli per contenere le conseguenze di errate azioni umane. Il cambiamento non è irreversibile ma si deve intervenire con una programmazione seria che riduca sostanzialmente i gas alteranti. Ci vuole la volontà pubblica e dei governi, oltre che privata. Il profitto non può essere sempre il principale obiettivo che muove le azioni. Per quanto riguarda l’affluenza turistica, per evitare un turismo “d’assedio”, si deve pensare di intervenire in modo più capillare sul territorio, valorizzando le valli secondarie, i luoghi meno conosciuti, meno popolati, creando condizioni che li rendano più appetibili, con infrastrutture di accoglienza, attività locali con proposte alternative… Molti turisti amano fare esperienza, entrare in contatto diretto con ciò che di naturale c’è nell’ambiente, senza che questo venga modificato per compiacerne le aspettative. Rallentare dunque, trovare un passo lento, assaporare i luoghi, integrarsi con le genti che li abitano, comprendere la diversità, scoprirne la poesia.
Esiste una relazione tra poesia e tutela dell’ambiente? Se sì, in che modo essa può aiutarci a sensibilizzare le persone sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale?
Voglio riportare come esempio una mia poesia, Ora di pranzo, che tratta la vicenda di un disastro ambientale, il crollo della discarica mineraria posta sopra il centro abitato di Tesero (Tn). La poesia fa parte della raccolta poetica Fatti reali immaginari (Arcipelago itaca, 2022) e si rifà a ciò che è avvenuto in Val di Stava nel 1984. La poesia è corredata da una nota che descrive la vicenda dal punto di vista storico. Qui uno stralcio: “Nel territorio comunale di Tesero e Varena c’è un giacimento minerario, il giacimento di Prestavèl, che già dalla prima metà del XVI secolo viene sfruttato per la produzione della galena argentifera. Dal 1941 si succedono diverse società nella gestione del giacimento minerario. La società Montecatini decide, negli anni sessanta, di costruire un impianto di flottazione per ottenere fluorite pura al 97-98% da destinare all’industria chimica. Il residuo di lavorazione è un fango che deve essere raccolto in bacini di discarica e decantazione. Il bacino di decantazione non deve superare i nove metri ma in realtà arriva a venticinque. Successivamente viene costruito, dal gruppo Montedison, un secondo bacino, posto più in alto rispetto al primo. Si è scelto per l’ubicazione di questi impianti un territorio acquitrinoso a elevata pendenza, instabile dal punto di vista idrogeologico. Si procede comunque a un ulteriore innalzamento. Nella relazione stesa il tecnico pare affermare «Strano che non sia già caduto». Gli argini dei due bacini arrivano a un’altezza complessiva che sfiora i sessanta i metri. Nel 1985 è la società Prealpi Mineraria che si occupa del giacimento. Il 19 luglio 1985, all’ora di pranzo, cede l’argine del bacino superiore e, a seguito di questo, collassa anche il bacino sottostante. Una parte del deposito fangoso, formato da centottantamila metri cubi, si riversa a scroscio nella valle alla velocità di novanta chilometri all’ora, distruggendo tutto ciò che trova: abitazioni, alberghi, capannoni, ponti, persone, animali, piante. Un forte boato, una nuvola di polvere. Si contano duecentosessantotto morti.
Ora di pranzo
19 luglio 1985, Tesero (Tn)
Tragedia della Val di Stava
È l’ora in cui si sta assieme.
Voce chiama dalla finestra mano posa il bicchiere
dito scava il pane braccio segna la croce
piede batte lo scalino occhio invade l’aria
piùdicentottantamilametricubidifango
stanno sospesi nell’alta valle, leggeri alle spalle,
quando l’ultima risata chiude la porta della stanza.
Da quanto stanno lì, in attesa di cadere?
Voi, lo sapete?
Proprio oggi –
tra un attimo – verranno
sgombrate le tavole rotte le sedie
tolti i gesti franti i vetri e l’aria
aperti i muri divelte le toppe erbose
sparecchiate le vite.
Potete immaginare le nostre mani alla bocca
che disfano il segno a croce,
l’ammucchiarsi dei corpi agli alberi,
il nostro [in sei minuti] infinito cadere?